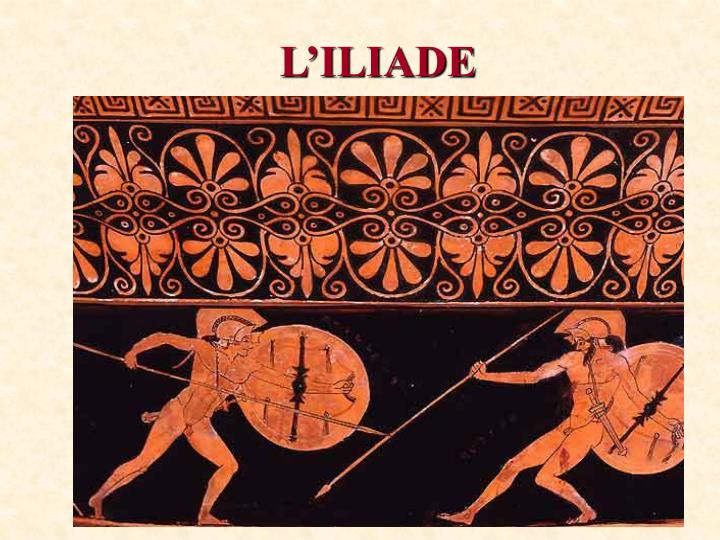 Pubblico la prima parte della mia tesi, come anticipato.
Pubblico la prima parte della mia tesi, come anticipato.
Buona lettura!
Fedeli a se stessi:
il rapporto oppresso-oppressore nelle riflessioni in Simone Weil.
Introduzione
Alle radici (greche) del culto della forza
Il rapporto oppresso-oppressore è un tema che attraversa ogni epoca.
Simone Weil, filosofa e scrittrice francese vissuta agli inizi del Novecento, ne aveva un’idea precisa. Nel 1933-1934 quando insegnava filosofia presso il liceo femminile di Roanne, e mentre si intravedeva già in questi anni la sua voglia di uscire dalle “retrovie”, dato che rimanere fedele a se stessa era uno dei suoi tratti caratteriali, esplicitava già questo tema nel testo Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale[1] dove, fin dalle prime righe, dominava l’argomentare sull'oppressione sociale.
“Se comprendessimo le cause dell’oppressione, non ci troveremmo più in questo stato insopportabile che consiste nel subirla, immersi nello smarrimento.”[2]
Occorreva dunque andare alla ricerca delle cause dell’oppressione nella società, cause che Simone Weil individuava in prima battuta nell’ambiente di lavoro, ma che approfondirà successivamente a partire dall’analisi delle forme in cui l’oppressione si era storicamente data, ovvero ricollegandole a un culto della forza con radici antichissime, che risalivano alla Grecia e proseguivano nell’Impero Romano e anche nella Francia del Cardinale Richelieu.
Difatti la cura – epimeleia – dei giovani nell’Atene del V sec. a.C., vale a dire il prendersi cura dei giovani per renderli eccellenti, (eccellere nella polis) equivaleva ad impartire loro come prima educazione - paideia - proprio l’arte della guerra, che portava inevitabilmente con sé l’uso della forza.
Nel Lachete[3] di Platone, due genitori preoccupati dell’educazione dei loro figlioli, Lisimaco e Melesia, durante l’esibizione di un combattimento di armi pesanti che non era propriamente addestramento militare, sentendo l’esigenza di una cura che servisse ai figlioli in vista dell’ingresso nella vita e in politica, (l’importante per un cittadino dell’epoca) per apprendere cosa fosse meglio insegnare loro al fine di farli divenire eccellenti cittadini, si affidavano appunto alle parole e all’esperienza militare del grande generale Nicia quale emblema dell’educatore, nonché modello pedagogico in vigore.
Ma quale ruolo poteva avere la guerra nell’educazione? E qual era il valore educativo del combattere con le armi?
Il mondo greco antico era fatto di competizione: l’agone sportivo diveniva il centro dell’educazione in preparazione alla guerra, poiché esercitare il fisico nel corpo a corpo e nella tattica era fondamentale in battaglia, nei momenti di conquista di nuove terre e nella difesa della propria, mentre in tempi di pace diveniva propedeutico, oltre che uno sbocco per lo sport. Dunque l’agone sportivo come preambolo all’utilizzo della vera forza, nella vera guerra, e la competizione avrebbe portato il vincitore, “l’eroe”. Il vincitore aveva raggiunto l’eccellenza.
Simone Weil descrive ampiamente la violenza di guerra nel suo poema L’Iliade o poema della Forza[4] del 1937, ma una breve riflessione sull’Iliade si trova già anche in Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale dove ella scrive:
«Il vero e proprio soggetto dell’Iliade è l’impero della guerra sui guerrieri e, mediante loro, su tutti gli esseri umani; nessuno sa perché ciascuno si sacrifichi, e sacrifichi tutti i suoi a una guerra micidiale senza oggetto, ed è per questo che, lungo tutto il poema, viene attribuito agli dèi l’influsso misterioso che fa fallire le trattative di pace, riaccende continuamente le ostilità, riporta indietro i combattenti che un lampo di ragione aveva spinto ad abbandonare la lotta. In questo antico e meraviglioso poema appare già in questo modo il male essenziale dell’umanità, la sostituzione dei mezzi ai fini»[5]
Weil riteneva infatti che non si trattasse di una questione di semplice interesse personale, perché un semplice egoismo o narcisismo non avrebbe potuto produrre mali così illimitati: riteneva invece che le attività dominanti l’esistenza sociale sacrificavano la vita umana propria e altrui sull’altare di oggetti, cose che servivano a viver meglio, ed erano sacrifici che si potevano riassumere in una sola parola: “potere”. Diceva infatti la filosofa che il potere è di norma un semplice mezzo: serve a superare la limitata forza singola posseduta da ciascuno, mentre quando viene ricercato, non potendo mai raggiungere il proprio oggetto, esclude la considerazione del “fine” arrivando persino a rovesciare il rapporto mezzo-fine, vale a dire abolendo ogni tipo di fine. Scrive Weil:
“È questo rovesciamento del rapporto tra il mezzo e il fine, è questa follia fondamentale che rende conto di tutto ciò che vi è d’insensato e di sanguinoso nel corso della storia. La storia dell’umanità viene a coincidere con la storia dell’asservimento che fa degli uomini, oppressi e oppressori, il puro zimbello degli strumenti di dominio che essi stessi hanno fabbricato, e riduce così l’umanità vivente ad esser cosa fra le cose inerti.”[6]
Una visione sempre attuale. Si potrebbe in effetti oggi dire che gli individui sono asserviti agli oggetti dell’industria bellica, all’ingente produzione di armamenti e munizioni presente in ogni Paese che essi stessi fabbricano, perché l’interesse economico ha superato di gran lunga quello sociale. Le armi sono strumenti di dominio per antonomasia.
Ne l’Iliade o poema della forza Simone Weil trova un dispositivo adatto ad interpretare la presa che la forza, la violenza e la guerra hanno sugli animi. Forza e violenza hanno la capacità di infiltrarsi nei corpi e nelle menti tanto da far dimenticare l’oggetto del contendere, spegnendo anche la capacità creativa dell’uomo di uscire dalla situazione contingente trovando valide alternative; la violenza, proprio come diceva René Girard, a un certo punto diventa una necessità perché tutto coinvolge, rendendo l’uomo che la subisce non solo incapace di sottrarsi ma addirittura incapace di riconoscerla, e così fomentarla.
“Arriva sempre il momento, a quanto sembra, in cui non ci si può più opporre alla violenza se non mediante un’altra violenza; e allora importa poco il successo o il fallimento, è sempre lei quella che vince. La violenza ha straordinari effetti mimetici, a volte diretti e positivi, a volte indiretti e negativi. Più gli uomini si sforzano di dominarla e più le danno alimento; essa trasforma in mezzi d’azione gli ostacoli che uno crede di opporle, simile in ciò a una fiamma che divora tutto quello che, con l’intenzione di spegnerla, le si può gettar sopra.”[7]
La forza come concetto cardine che nell’Iliade aleggia su chiunque é una potenza “illimitata” e “prodigiosa” capace di trasformare e reificare gli esseri umani; mostra Achille posseduto dalla forza tanto quanto Ettore, è l’impero della guerra sui guerrieri, una violenza divenuta fine a se stessa, dimentica del proprio oggetto, e perciò il poema omerico evidenzia la miseria di tutti, sia achei che troiani, con amarezza[8]. Non vi é più un fine, non si sa più perché bisogna lottare, e tuttavia la forza esercita un dominio e il sacrificio continua.
Ma l’educazione alla guerra dei giovani nella Grecia antica ci porta altresì a considerare che l’esercizio della forza usata dagli uomini era nella sua essenza una forza a sua volta assoggettata alla sottomissione: la superiorità indirizzata all’asservimento. L’anima umana - venendo accecata dalla forza che credeva di possedere - cercava il trofeo nell’anima del guerriero di fronte. L’anima nell’epica omerica è lo spirito che risiede nel corpo umano e che fuoriesce da esso, dopo la morte, dalla bocca.
Se da una parte è vero che la forza inebria chi la possiede e l’obiettivo è il dominio delle anime, dall’altra non bisogna però dimenticare che l’eccellenza greca riguardava anche la coltivazione dello spirito (psyché)[9]; il rapporto della paideia come cura di sé era altrettanto esercizio individuale. L’eroe omerico si distingueva certamente per il suo coraggio e la condotta esemplare, senza dubbio per l’abilità con la lancia, ma ugualmente per la competenza e le doti oratorie.
Sebbene il dialogo del Lachete risulti infine aporetico, sarà Socrate a lasciar intuire a Lisimaco e Melesia l’arcano scopo della paideia: l’oggetto della cura dei giovani era in verità l’anima e ciò avrebbe reso il corpo kalòs kai agathòs, bello di bellezza virtuosa, il bello e buono sia nell’anima che nel fisico. La più alta aspirazione del mondo greco era infatti unire la bellezza fisica a quella spirituale. La natura dell’anima sarebbe, nel dialogo, un certo tipo di fortezza ovvero Logos unito a una dimensione pratica; “il coraggio sarebbe una forza accompagnata dall’intelligenza”[10] dice Socrate, è un saper fare assennato, e in ultima analisi quel collegare l’azione al pensiero che è caratteristica prima di Simone Weil: la linearità tra le azioni e le parole[11], far seguire al pensiero un’azione, il che equivale a rimanere sempre fedele a se stessa.
[1] Giancarlo Gaeta, Leggere Simone Weil, Quodlibet, Macerata (2018), pp. 35-36.
[2] Simone Weil, Lezioni di Filosofia, raccolte da Anne Reynaud-Guérithault, a cura di Maria Concetta Sala, trad. it. di Luisa Nocentini, Adelphi, Milano (1999), p.143.
[3] Platone, Lachete, traduzione e note di Giovanni Reale, Bompiani, Milano (2015), pp. 123.
[4] S. Weil, L’Iliade o il poema della forza, trad. it. di Francesca Rubini, Asterios, Trieste, (2015).
[5] S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà ed oppressione sociale, a cura di Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano (2015), pp. 53-54.
[6] Ivi, pp. 54-55.
[7] René Girard, La violenza e il sacro, tr. it. di Ottavio Fatica e Eva Czerkl, Adelphi, Milano (1980), p. 52.
[8] S. Weil, L’Iliade o il poema della forza, cit., p.72
[9] Platone, Lachete, cit., pp. 147-151
[10] Ivi, p. 183
[11] Ivi, pp.189-191











