1.3 La questione coloniale
La questione coloniale era da sempre stata presente nel pensiero di Simone Weil, sin dalle prime esperienze di lavoro in fabbrica e sindacato, quando aveva provato di persona l’oppressione per la prima volta. Lei, che proveniva da una famiglia colta e agiata, per meglio capire le condizioni materiali del lavoro aveva voluto sperimentare direttamente il lavoro in fabbrica, per rendersi conto di cosa significasse lavorare alla catena di montaggio di una grande industria. Ma della questione coloniale parlò diffusamente solo nell’ultimo periodo della sua vita, una volta giunta a Londra per lavorare con France Libre, l’organizzazione politico-militare di resistenza anti-nazista creata dal Generale De Gaulle durante la seconda guerra mondiale, che attirava intellettuali francesi. L’anticolonialismo di Simone Weil nacque perciò molto presto, dalla consapevolezza che l’oppressione colpiva pesantemente gli abitanti delle molte colonie francesi.
La prima volta che si era sentita coinvolta in questa storia aveva solo ventuno anni e fu a causa della sanguinosa repressione attuata a Yen Bai in Indocina (Tonchino), nel 1930:[1] gli indigeni erano stati uccisi per la loro voglia di indipendenza. Lei lo aveva saputo dal quotidiano.
Come ogni mattina passava a ritirare le Petit Parisien, il giornale che leggeva a pranzo, dove il giornalista e scrittore Louis Roubaud[2] aveva scritto un’inchiesta coraggiosa e ben documentata. La tragedia indocinese scaturiva dalla rivalsa francese per l’uccisione di suoi ufficiali ad opera della guardia indocinese, e la risposta francese aveva fatto secondo alcune stime 10.000 vittime tra contadini e popolazione civile, una repressione enorme e spietata che tornerà nei suoi scritti costantemente. Nel leggere delle violenze e dell’uccisione degli operai ammanniti, impotenti di fronte a tanta forza bruta, lacrime di vergogna le avevano rigato il viso e racconta che l’anno successivo, il 1931 periodo dell’esposizione coloniale internazionale di Parigi,[3] percepiva palpabile la contraddizione esistente tra la tranquilla e incosciente folla parigina piena di ammirazione del Tempio di Angkor-vat, e la loro indifferenza rispetto alle sofferenze inflitte a quel popolo proprio dal colonialismo francese.






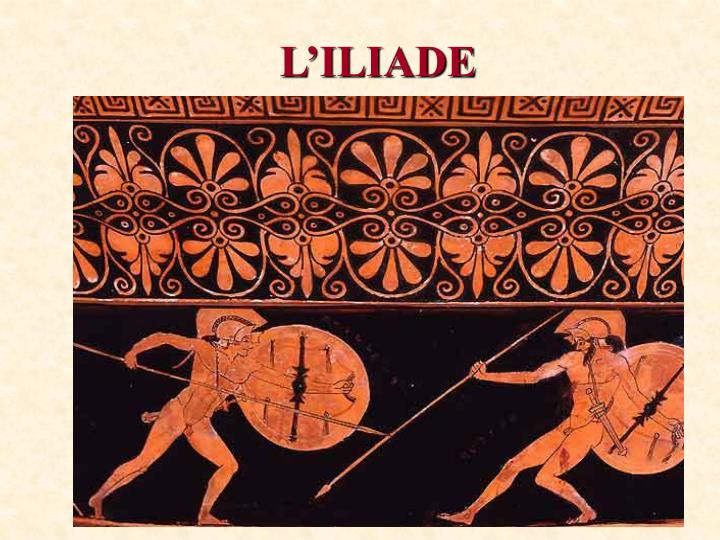 Pubblico la prima parte della mia tesi, come anticipato.
Pubblico la prima parte della mia tesi, come anticipato.  Nella ricorrenza della nascita dell'
Nella ricorrenza della nascita dell'



